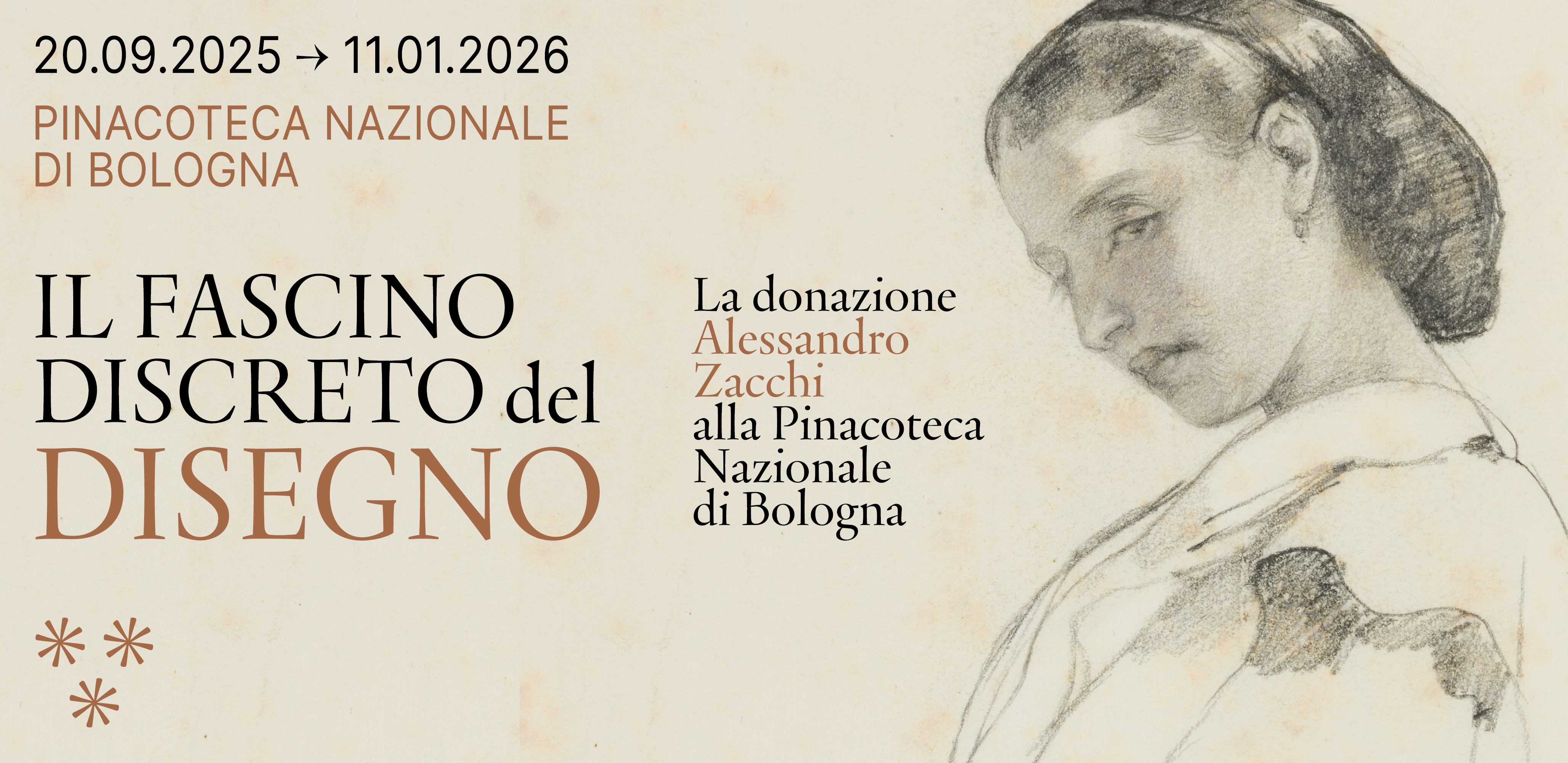La Pinacoteca Nazionale di Bologna nasce nel 1808 come quadreria dell’Accademia di Belle Arti, l’istituto d’istruzione sorto dalle ceneri della settecentesca Accademia Clementina. L’antico nucleo, proveniente dall’Istituto delle Scienze, fu in seguito arricchito dalla straordinaria raccolta di quasi mille dipinti frutto delle soppressioni di chiese e conventi compiute dopo l’ingresso delle truppe napoleoniche a Bologna, tra il 1797 e il 1810, e nuovamente a seguito delle soppressioni del 1866 attuate dal nuovo stato italiano.
Nella sede distaccata di Palazzo Pepoli Campogrande è possibile ammirare le sale splendidamente affrescate dai principali protagonisti della grande decorazione bolognese tra la seconda metà del Seicento e gli inizi del secolo successivo: il Salone d’onore con la trionfale Apoteosi di Ercole di Canuti, la Sala di Felsina con le pitture composte e aggraziate dei fratelli Rolli, le sale delle Stagioni e dell’Olimpo, dove l’irriverente Giuseppe Maria Crespi contamina la decorazione celebrativa con i modi della pittura di genere, l’elegante classicismo della Sala di Alessandro di Donato Creti. Gli ambienti del piano nobile di Palazzo Pepoli Campogrande ospitano alle pareti alcuni dipinti della quadreria Zambeccari, la ricca collezione destinata alla pubblica fruizione a fine Settecento dal marchese Giacomo Zambeccari ed entrata a far parte delle raccolte della Pinacoteca nel 1884.
Avvisi ai visitatori
- Giovedì 27 novembre 2025 la Pinacoteca sarà chiusa al pubblico dalle ore 12:30 alle ore 14:30 per Assemblea sindacale. I visitatori presenti all'interno del museo durante la mattina dovranno recarsi fuori entro le 12:15 e potranno rientrare alla riapertura del museo alle 14:30. Ci scusiamo per i possibili disagi.
- Dall’1 luglio 2024 Palazzo Pepoli Campogrande è chiuso al pubblico per lavori di ristrutturazione e adeguamento tipologico funzionale. La riapertura è prevista per la primavera 2026.
Notices to visitors
- On Thursday, November 27, 2025 from 12:30 PM to 2:30 PM, the Pinacoteca will be closed to the public for a union meeting. All visitors are requested to leave the museum by 12:15 PM and may return when we reopen at 2:30 PM. We apologize for the inconvenience.
- As of 1 July 2024 Palazzo Pepoli Campogrande is closed to the public for renovation and function-related upgrading. It is scheduled to reopen in spring of 2026.

In evidenza:
Resa nota dal Longhi (1946), è databile al periodo giovanile del grande pittore cretese, verso il 1567, circa gli stessi anni del Polittico di Modena.
L'artista dimostra di tenere presente sia l'Ultima Cena dipinta da Tintoretto per San Marcuola, che quella di Salviati oggi a Santa Maria della Salute, pur affrontando il tema con il caratteristico cromatismo di derivazione bizantina.
Identificabile con un dipinto ad analogo soggetto che il Malvasia ricordava nella chiesa di Santa Maria Maddalena, è opera assai vicina all'attività del Bagnacavallo, con cui Pupini collaborò a lungo; a lui lo accomunano il tocco rapido e un'interpretazione di Raffaello in chiave cromatica e naturalizzata.
È palese il richiamo al concerto angelico della Santa Cecilia.
Per molto tempo è stata ritenuta opera del giovane Tibaldi.
Si collega agli esempi qualitativamente più alti del tardo raffaellismo bolognese-ferrarese (Girolamo da Carpi e da Treviso), riflettendo nello sfondo una spiccata attenzione al paesaggio di Nicolò dell'Abate.
È una delle numerose copie e derivazioni tratte dal celebre dipinto raffaellesco commissionato dal cardinale Pompeo Colonna e donato al medico fiorentino Jacopo da Carpi, quasi unanimemente identificato con quello oggi esposto nella Tribuna degli Uffizi a Firenze.
Come l'altra versione del palazzo del Quirinale a Roma, fu già attribuito a Giulio Romano.
Già attribuita all'attività giovanile del Tibaldi, quest'opera ha consentito - in seguito alla scoperta della firma nel corso di un restauro - di avviare la ricostruzione critica dell'attività del Ramenghi Junior.
Si colloca oltre la metà del secolo, dopo che l'artista era stato a Fontainebleau al seguito del Primaticcio e a Roma col Vasari, e rivela notevoli affinità con la pala di Girolamo Siciolante sull'altar maggiore della chiesa di San Martino (1548).