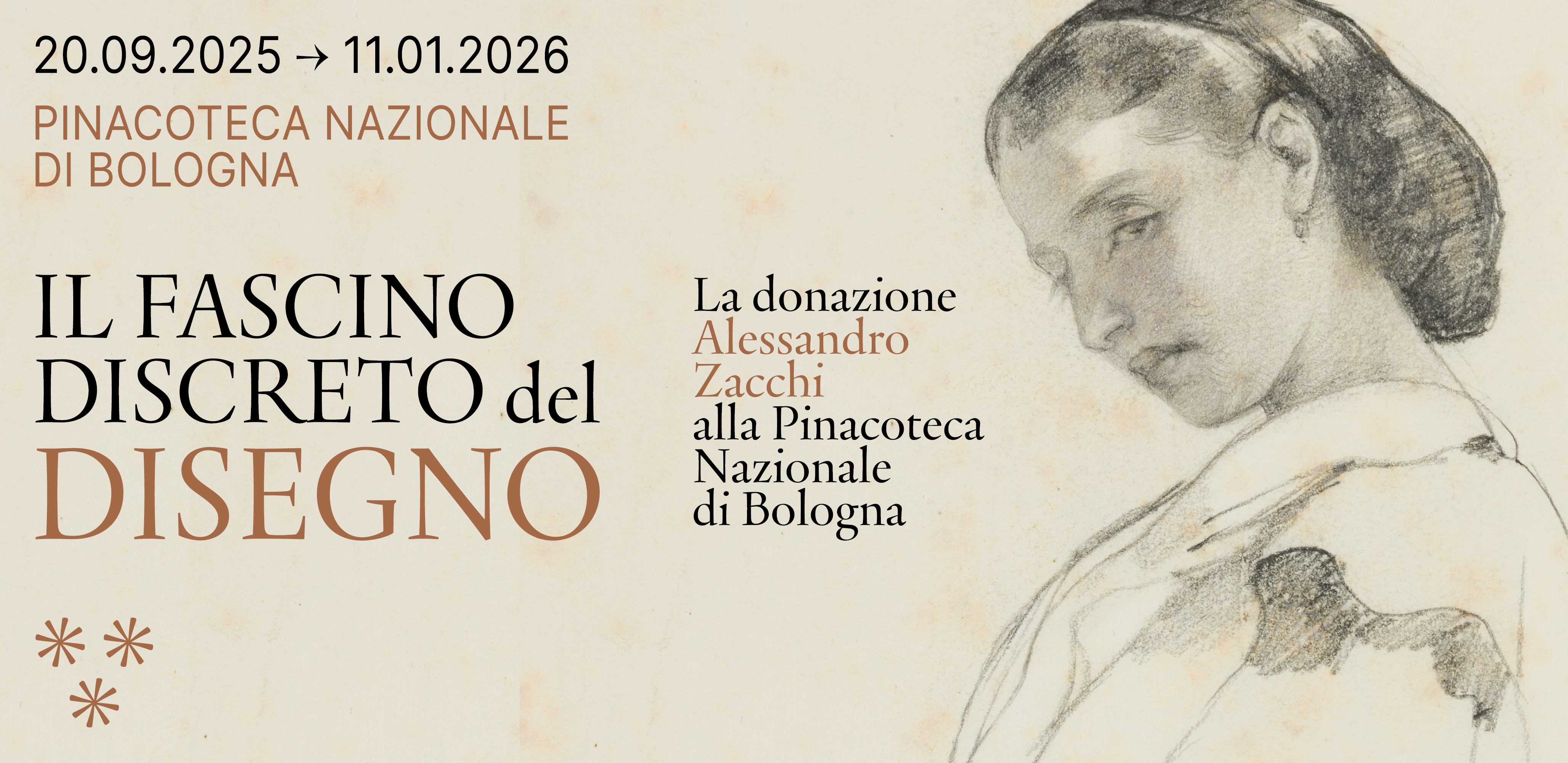La Pinacoteca Nazionale di Bologna nasce nel 1808 come quadreria dell’Accademia di Belle Arti, l’istituto d’istruzione sorto dalle ceneri della settecentesca Accademia Clementina. L’antico nucleo, proveniente dall’Istituto delle Scienze, fu in seguito arricchito dalla straordinaria raccolta di quasi mille dipinti frutto delle soppressioni di chiese e conventi compiute dopo l’ingresso delle truppe napoleoniche a Bologna, tra il 1797 e il 1810, e nuovamente a seguito delle soppressioni del 1866 attuate dal nuovo stato italiano.
Nella sede distaccata di Palazzo Pepoli Campogrande è possibile ammirare le sale splendidamente affrescate dai principali protagonisti della grande decorazione bolognese tra la seconda metà del Seicento e gli inizi del secolo successivo: il Salone d’onore con la trionfale Apoteosi di Ercole di Canuti, la Sala di Felsina con le pitture composte e aggraziate dei fratelli Rolli, le sale delle Stagioni e dell’Olimpo, dove l’irriverente Giuseppe Maria Crespi contamina la decorazione celebrativa con i modi della pittura di genere, l’elegante classicismo della Sala di Alessandro di Donato Creti. Gli ambienti del piano nobile di Palazzo Pepoli Campogrande ospitano alle pareti alcuni dipinti della quadreria Zambeccari, la ricca collezione destinata alla pubblica fruizione a fine Settecento dal marchese Giacomo Zambeccari ed entrata a far parte delle raccolte della Pinacoteca nel 1884.
Avvisi ai visitatori
- Giovedì 27 novembre 2025 la Pinacoteca sarà chiusa al pubblico dalle ore 12:30 alle ore 14:30 per Assemblea sindacale. I visitatori presenti all'interno del museo durante la mattina dovranno recarsi fuori entro le 12:15 e potranno rientrare alla riapertura del museo alle 14:30. Ci scusiamo per i possibili disagi.
- Dall’1 luglio 2024 Palazzo Pepoli Campogrande è chiuso al pubblico per lavori di ristrutturazione e adeguamento tipologico funzionale. La riapertura è prevista per la primavera 2026.
Notices to visitors
- On Thursday, November 27, 2025 from 12:30 PM to 2:30 PM, the Pinacoteca will be closed to the public for a union meeting. All visitors are requested to leave the museum by 12:15 PM and may return when we reopen at 2:30 PM. We apologize for the inconvenience.
- As of 1 July 2024 Palazzo Pepoli Campogrande is closed to the public for renovation and function-related upgrading. It is scheduled to reopen in spring of 2026.

In evidenza:
La tavola, assieme al Sant’Ubaldo Vescovo (inv. 313), costituivano rispettivamente il pannello centrale e quello laterale sinistro di un trittico o di un più ampio polittico smembrato di cui non si ha notizia. La presenza di sant’Ubaldo, vescovo e patrono di Gubbio, consente di indirizzare la realizzazione verso l’area umbro-marchigiana, dove il culto del santo trovò diffusione e dove ne sopravvivono diverse testimonianze iconografiche. Caratteristiche del maestro a cui sono state attribuite le due tavole sono la definizione gracile e sottile delle fisionomie e la definizione psicologica pacata dei personaggi.
Come nel Santo Apostolo (inv. 7155), la mancanza di attributi iconografici non consente una precisa identificazione; i due Santi, assieme al San Pietro e al San Giacomo già in collezione Berenson a Settignano e ora di proprietà dello Harvard Center of Renaissance Studies, in origine trovavano posto nei pilastri laterali di un polittico già sull’altare della famiglia Sandei nella chiesa di Santa Sofia a Venezia. Nelle tavolette l’eleganza e l’estrema perizia di esecuzione, tipiche dell’artista marchigiano, si uniscono a una straordinaria monumentalità, probabile rimando alla scultura veneziana coeva.
In origine probabilmente parte centrale di un polittico smembrato, la tavola richiama l’opera di Michele di Matteo di analogo soggetto conservata ai Musei Civici di Pisa. Sebbene non all’altezza dei dipinti precedenti del pittore bolognese, la scena si distingue per il preziosismo della tecnica, evidente nella ricca veste della Vergine, nei bordi a elementi geometrici del manto di Cristo e nei motivi decorativi delle due corone-aureole.
Il polittico venne commissionato, probabilmente da Giovanni di Mattiolio 'Merciaio' come appare nell'iscrizione in basso sulla tavola centrale.
Si trovava nella chiesa del convento femminile delle suore domenicane di S. Pietro Martire in Bologna.
Nulla nella sua iconografia rimanda però a questa sede tranne il colore bianco e nero che appare nelle delle vesti dei santi della predella.
Come nel Santo Apostolo con libro (inv. 7156), la mancanza di attributi iconografici non consente una precisa identificazione; i due Santi, assieme al San Pietro e al San Giacomo già in collezione Berenson a Settignano e ora di proprietà dello Harvard Center of Renaissance Studies, in origine trovavano posto nei pilastri laterali di un polittico già sull’altare della famiglia Sandei nella chiesa di Santa Sofia a Venezia. Nelle tavolette l’eleganza e l’estrema perizia di esecuzione, tipiche dell’artista marchigiano, si uniscono a una straordinaria monumentalità, probabile rimando alla scultura veneziana coeva.
Questa tavola, che segue in modo ormai stanco le cadenze tardogotiche, insieme ad altre due raffiguranti Sant'Andrea Corsini, San Procardo, fu eseguita dal maestro nella tarda maturità , dopo il ritorno da Siena.
Interessante la presenza del Sant'Andrea Corsini, inserito nel calendario carmelitano solo nel 1462.
L'opera fu commissionata a date decisamente tarde da quello stesso ordine e per la stessa chiesa che aveva visto attivo nel 1437 Paolo Uccello.
La ricostruzione iconografica si deve a P. Antonio Pinci.