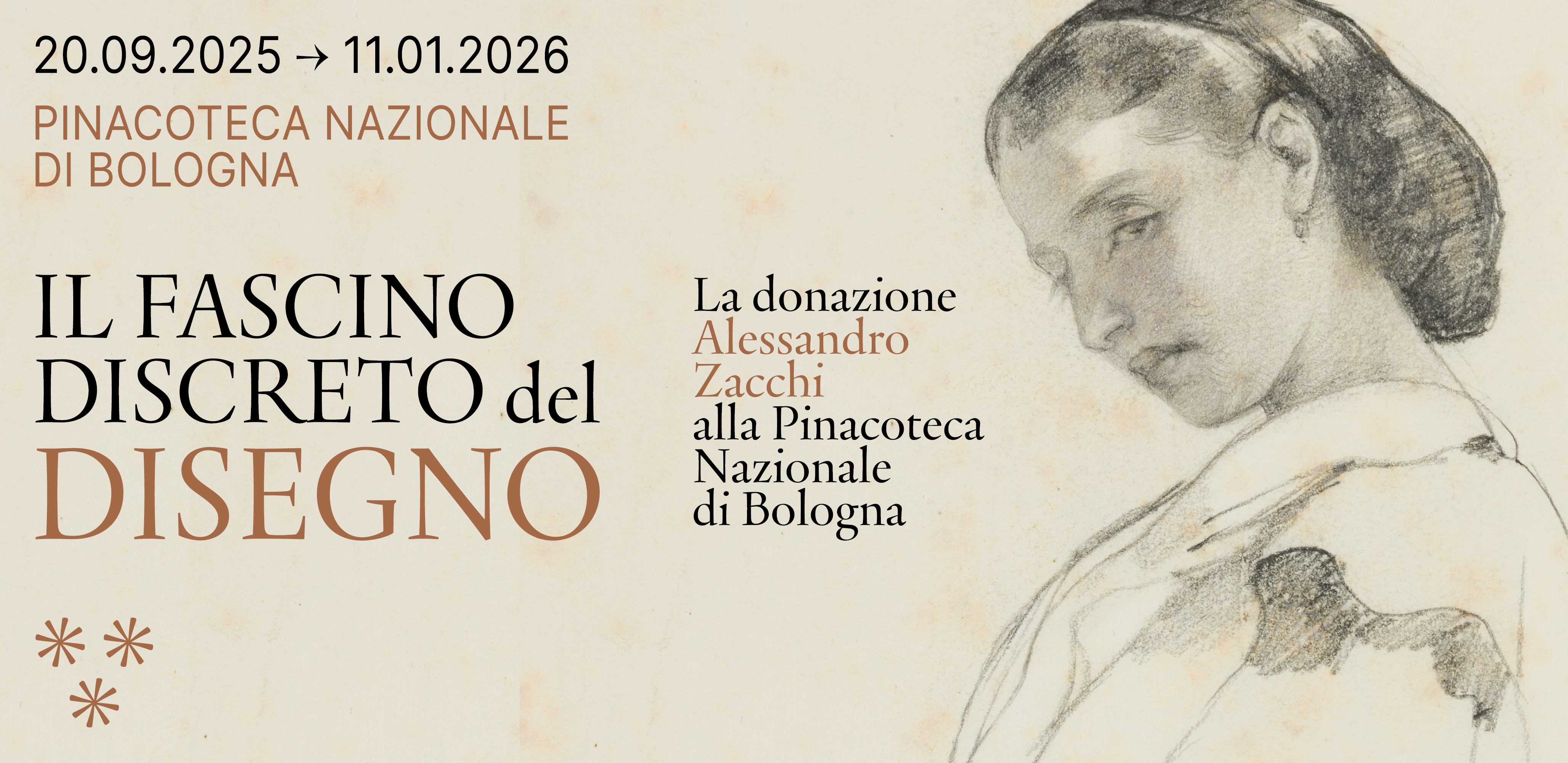La Pinacoteca Nazionale di Bologna nasce nel 1808 come quadreria dell’Accademia di Belle Arti, l’istituto d’istruzione sorto dalle ceneri della settecentesca Accademia Clementina. L’antico nucleo, proveniente dall’Istituto delle Scienze, fu in seguito arricchito dalla straordinaria raccolta di quasi mille dipinti frutto delle soppressioni di chiese e conventi compiute dopo l’ingresso delle truppe napoleoniche a Bologna, tra il 1797 e il 1810, e nuovamente a seguito delle soppressioni del 1866 attuate dal nuovo stato italiano.
Nella sede distaccata di Palazzo Pepoli Campogrande è possibile ammirare le sale splendidamente affrescate dai principali protagonisti della grande decorazione bolognese tra la seconda metà del Seicento e gli inizi del secolo successivo: il Salone d’onore con la trionfale Apoteosi di Ercole di Canuti, la Sala di Felsina con le pitture composte e aggraziate dei fratelli Rolli, le sale delle Stagioni e dell’Olimpo, dove l’irriverente Giuseppe Maria Crespi contamina la decorazione celebrativa con i modi della pittura di genere, l’elegante classicismo della Sala di Alessandro di Donato Creti. Gli ambienti del piano nobile di Palazzo Pepoli Campogrande ospitano alle pareti alcuni dipinti della quadreria Zambeccari, la ricca collezione destinata alla pubblica fruizione a fine Settecento dal marchese Giacomo Zambeccari ed entrata a far parte delle raccolte della Pinacoteca nel 1884.
Avvisi ai visitatori
- Per lavori di ristrutturazione l'aula Cesare Gnudi è chiusa mercoledì 22 ottobre e dal 3 al 6 novembre 2025. Ci scusiamo per il disagio.
- Dall’1 luglio 2024 Palazzo Pepoli Campogrande è chiuso al pubblico per lavori di ristrutturazione e adeguamento tipologico funzionale. La riapertura è prevista per la primavera 2026.
Notices to visitors
- Due to renovation works, the Cesare Gnudi room is closed on Wednesday 22 October and from 3 to 6 November 2025. We apologise for any inconvenience..
- As of 1 July 2024 Palazzo Pepoli Campogrande is closed to the public for renovation and function-related upgrading. It is scheduled to reopen in spring of 2026.

In evidenza:
Il Sansone vittorioso, tra i più celebri dipinti di Guido Reni, fu commissionato dal conte Luigi Zambeccari come decorazione per un camino della sua casa in via Riva di Reno a Bologna. L’opera fu poi acquistata dal cardinale Girolamo Boncompagni per sottrarla alla vendita all’estero e donata al Senato cittadino nel 1684.
Sansone, il valoroso combattente dell’Antico Testamento, è raffigurato sul campo di battaglia mentre beve dalla mascella d’asino con la quale ha appena ucciso mille Filistei esemplificati nei corpi riversi a terra, su più piani.
Un errore dell’antica traduzione del testo biblico aveva confuso il nome del luogo della battaglia, denominato monte della Mascella, con l’osso medesimo, generando l’iconografia che vediamo in cui l’acqua non sgorga da una fenditura della roccia, ma dalla mascella stessa.
Sansone è l’espressione più alta di quell’ideale di equilibrio, bellezza e armonia a cui Guido Reni si ispirava. Per raffigurarlo il pittore studia una posa che recupera il modello della statua classica dell’Apollo del Belvedere oggi ai Musei Vaticani.
Il filtro della bellezza antica annulla ogni traccia di sofferenza e di affaticamento per la lotta appena compiuta. Un maggiore naturalismo si rintraccia, invece, nei corpi dei Filistei, ammassati a terra, sanguinanti e tragici, lasciati nell’ombra in forte contrasto con la luminosità del Sansone vincitore.
Il dipinto, appartenuto da sempre alla famiglia Hercolani, di cui decorava la cappella del palazzo di Castelmaggiore, è un abbozzo evidente, condotto in talune parti più a compimento che in altre.
Tuttavia Reni vi raggiunge, come sempre, un grado di perfezione spirituale e ideale assoluto, tipico della sua fase artistica estrema, quando alla necessità economica di finire in fretta i dipinti s'intreccia la sua forte crisi esistenziale e poetica.
Si tratta di un'opera dell'ultimo periodo di attività di Reni, caratterizzato da toni di colore sempre più spenti e dalla progressiva evanescenza delle pennellate.
La figura di Cristo, dolente e fisicamente rassegnato sotto i colpi del flagello, vince spiritualmente sugli aguzzini dalle anatomie ben delineate, ma ormai prive dell'incisività statuaria presente nelle opere giovanili dell'artista.
Il dipinto, per gli evidenti echi della cultura manierista del Calvaert, è riferibile all'attività giovanile di Guido Reni (circa 1595-1598).
L'opera si caratterizza anche per l'impaginazione direttamente ispirata all'Estasi di Santa Cecilia di Raffaello.
Sulla scorta di un passo del Malvasia (1678), questo dipinto è stato tradizionalmente ritenuto il ritratto della madre dell'artista anche se questa identificazione non è confortata da alcun riscontro.
Si tratta di un'opera di altissimo livello sia per la profondità psicologica che per lo straordinario accordo tonale, degna di essere ricordata come uno dei più bei ritratti di tutto il Seicento italiano.
È la prima delle grandi composizioni su questo tema eseguite da Reni ed è databile intorno al 1617.
Si tratta di un'opera importantissima che è valsa a fissare uno dei prototipi dell'iconografia cristologica dal Seicento ai giorni nostri, riprodotta in infinite copie integrali o parziali.