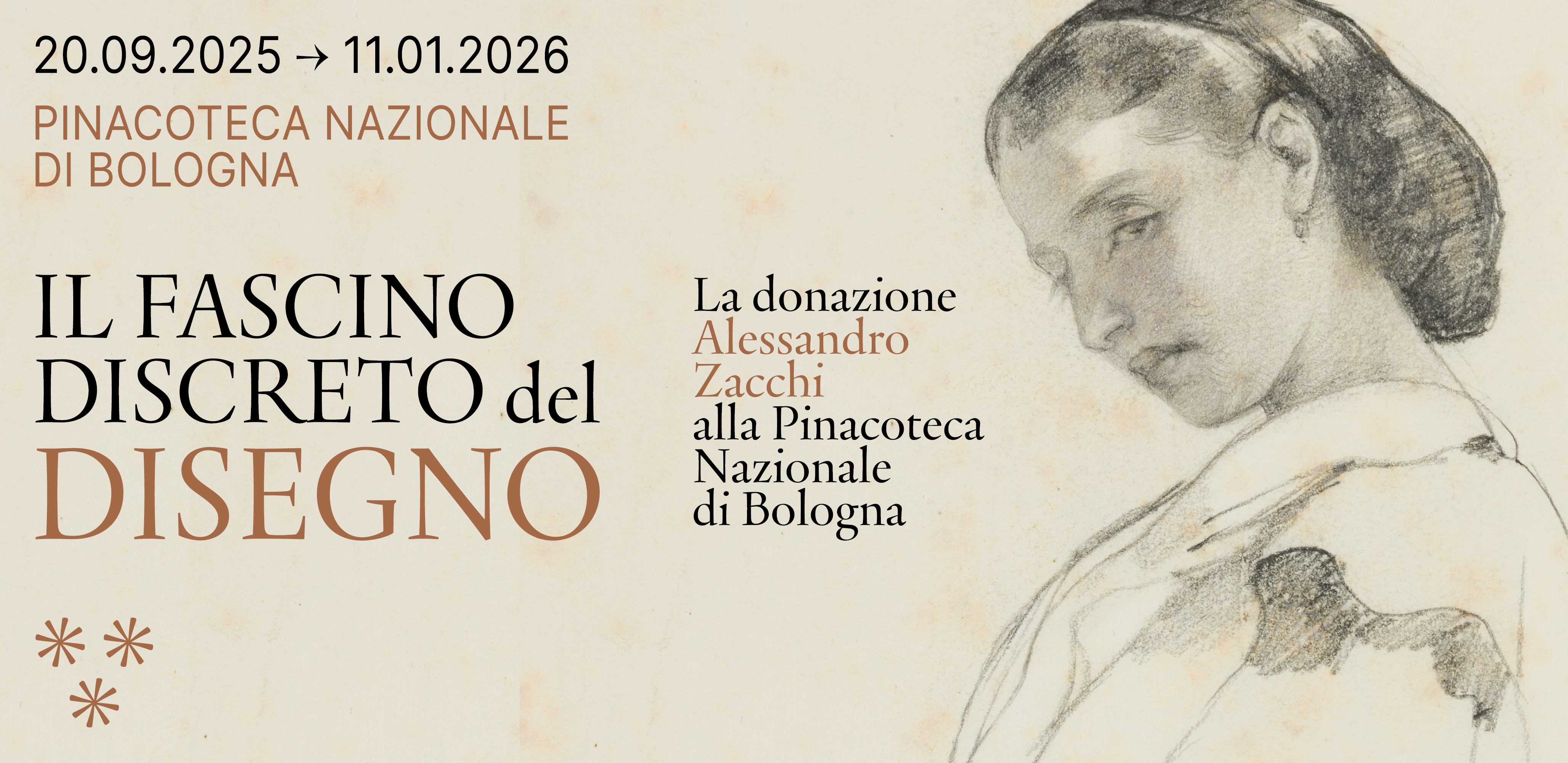La Pinacoteca Nazionale di Bologna nasce nel 1808 come quadreria dell’Accademia di Belle Arti, l’istituto d’istruzione sorto dalle ceneri della settecentesca Accademia Clementina. L’antico nucleo, proveniente dall’Istituto delle Scienze, fu in seguito arricchito dalla straordinaria raccolta di quasi mille dipinti frutto delle soppressioni di chiese e conventi compiute dopo l’ingresso delle truppe napoleoniche a Bologna, tra il 1797 e il 1810, e nuovamente a seguito delle soppressioni del 1866 attuate dal nuovo stato italiano.
Nella sede distaccata di Palazzo Pepoli Campogrande è possibile ammirare le sale splendidamente affrescate dai principali protagonisti della grande decorazione bolognese tra la seconda metà del Seicento e gli inizi del secolo successivo: il Salone d’onore con la trionfale Apoteosi di Ercole di Canuti, la Sala di Felsina con le pitture composte e aggraziate dei fratelli Rolli, le sale delle Stagioni e dell’Olimpo, dove l’irriverente Giuseppe Maria Crespi contamina la decorazione celebrativa con i modi della pittura di genere, l’elegante classicismo della Sala di Alessandro di Donato Creti. Gli ambienti del piano nobile di Palazzo Pepoli Campogrande ospitano alle pareti alcuni dipinti della quadreria Zambeccari, la ricca collezione destinata alla pubblica fruizione a fine Settecento dal marchese Giacomo Zambeccari ed entrata a far parte delle raccolte della Pinacoteca nel 1884.
Avvisi ai visitatori
- Per lavori di ristrutturazione l'aula Cesare Gnudi è chiusa mercoledì 22 ottobre e dal 3 al 6 novembre 2025. Ci scusiamo per il disagio.
- Dall’1 luglio 2024 Palazzo Pepoli Campogrande è chiuso al pubblico per lavori di ristrutturazione e adeguamento tipologico funzionale. La riapertura è prevista per la primavera 2026.
Notices to visitors
- Due to renovation works, the Cesare Gnudi room is closed on Wednesday 22 October and from 3 to 6 November 2025. We apologise for any inconvenience..
- As of 1 July 2024 Palazzo Pepoli Campogrande is closed to the public for renovation and function-related upgrading. It is scheduled to reopen in spring of 2026.

In evidenza:
Opera databile intorno al 1639, si caratterizza per lo straordinario rapporto prospettico di luce e colore tra la figura e il fondo e per il solenne atteggiarsi del santo che, fissato in un attimo di idealizzata sospensione, domina il misurato spazio rettangolare.
L’opera fu commissionata a Guido Reni, l’artista più rinomato di Bologna, dall’allora Governo della città, come un pallione, vale a dire uno stendardo da portare in processione ogni anno dal Palazzo Pubblico alla Chiesa di San Domenico, in ringraziamento per la fine della peste del 1630.
L’epidemia, la stessa descritta da Alessandro Manzoni nei “Promessi sposi” che aveva colpito tutta Italia, aveva infuriato in città, causando ben ventimila decessi su settantamila abitanti.
In vista della futura utilizzazione, Guido Reni decise di dipingere su seta, com’era consuetudine per i pallioni processionali.
La grande pala è strutturata in una composizione suddivisa in tre fasce: in quella centrale si dispongono a corona per intercedere per la città. i tradizionali Santi protettori di Bologna, Petronio, Procolo, Francesco d’Assisi Floriano e Domenico, a cui si aggiungono i fondatori della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola e Francesco Saverio.
Nella parte superiore la Vergine, seduta su un trono di nubi entro una gloria di angeli, tocca con i piedi l’arcobaleno, simbolo di pacificazione, che illumina con la sua luce il grigio del cielo.
In basso, avvolta da nubi plumbee è raffigurata la città di Bologna, dalle cui mura escono i carri dei monatti.
Lo schema tradizionale della composizione, l’uso sapiente della luce che passa dal grigio scuro della città spopolata dall’epidemia fino alla luminosità dorata che emana dalla figura della Vergine ben si accorda con la funzione del dipinto - inserito unanimemente dalla critica tra capolavori di Guido Reni – come un grande quadro votivo, capace di esprimere i sentimenti insieme di dolore e di gratitudine dell’intera città.
Ordinata all'artista dal Senato di Bologna, fu collocata sull'altare maggiore della chiesa di Santa Maria della Pietà il 13 novembre 1616.
L'opera propone un ordine compositivo alquanto antico e tipico delle sacre conversazioni cinquecentesche (Raffaello, Estasi di Santa Cecilia), mentre l'intimo patetismo religioso rimanda al maestro Ludovico Carracci (La nascita del Battista).
Cantarini completò la propria formazione a Bologna nello studio di Guido Reni del quale seppe in breve tempo guadagnarsi la stima.
L'immagine di Reni che il pennello di Cantarini restituisce è caratterizzata da una severa ed umana nobiltà, priva di enfasi retorica.
L'opera è riferibile al 1635-1636 circa.
Fu compreso dal Malvasia (1678) fra le opere della vecchiaia di Reni, che l'avrebbe affrettatamente abbozzato per ragioni di più rapido commercio.
Si tratta di un dipinto di eccezionale qualità pittorica, in cui l'artista riesce ad esprimere, con un accentuato senso di levitazione della materia, un'intensissima sostanza poetica.